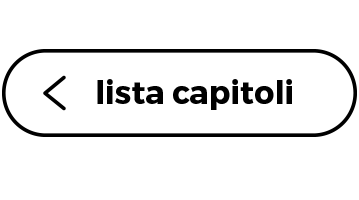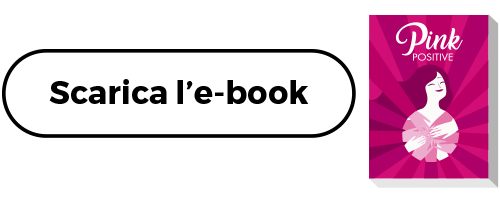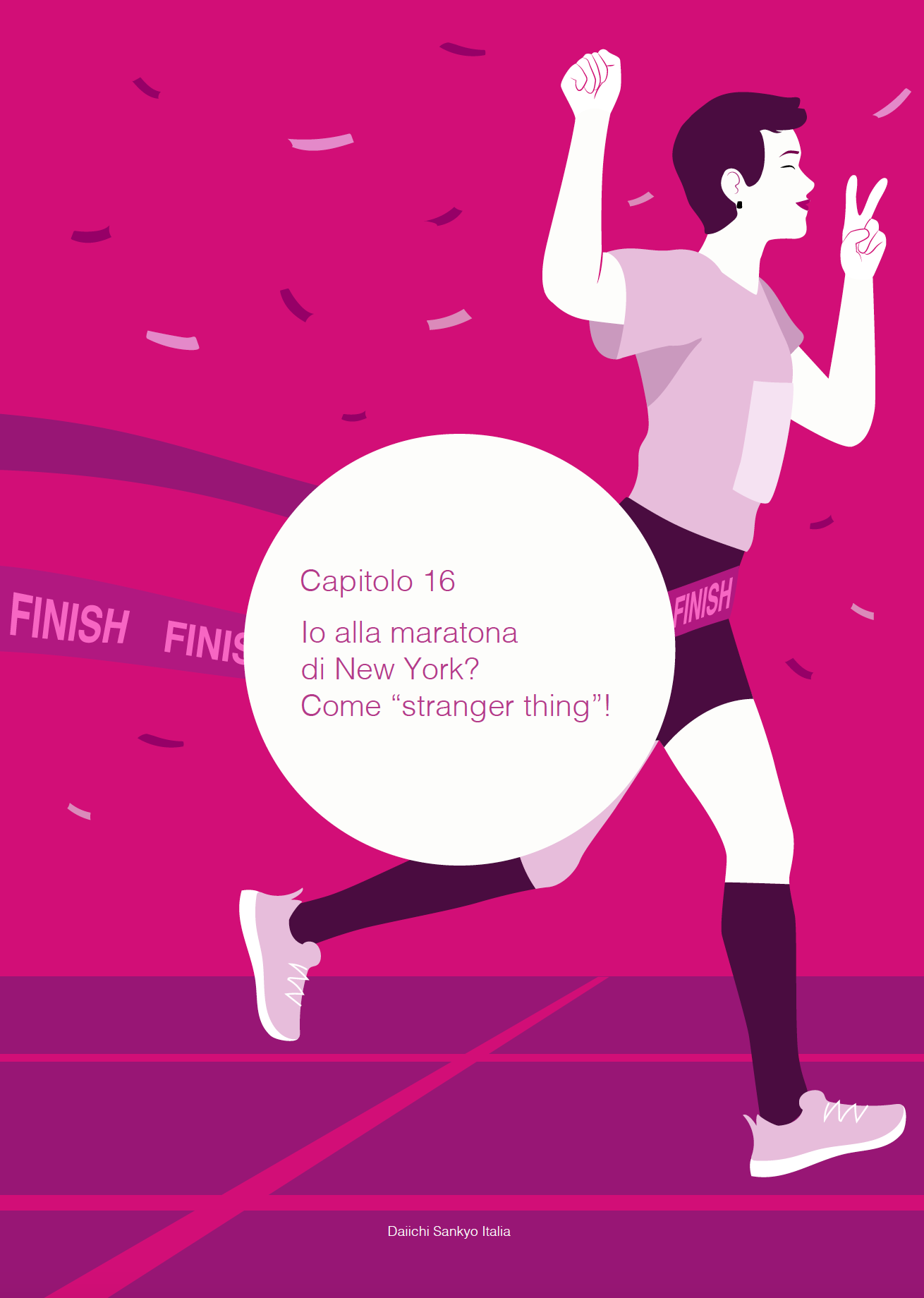Capitolo 16

Dalla paralisi alla corsa più famosa, passando attraverso due tumori
Il successo della serie TV “Stranger Things” ci ha insegnato come i ragazzini di 13 anni, durante i primi anni ’80, trascorressero il loro tempo tra lunghe conversazioni col walkie-talkie, sessioni interminabili di Pac-Man in sala giochi, combattimenti contro le creature immaginarie di Dungeons&Dragons e i primi amori. Nonostante questi ultimi fossero accolti dai compagni come reati di lesa maestà nei confronti delle amicizie che non conoscono compromessi. Nonostante la minaccia ultraterrena del Sottosopra e quella, non meno incombente e spaventosa, dell’età adulta, facciano sentire il loro sinistro brontolio come nuvole cariche d’elettricità all’orizzonte. Monica ha 13 anni nel 1983, come i protagonisti di “Stranger Things”. E proprio come loro è finita in una specie di Sottosopra. Una mattina, mentre era a scuola, ha avvertito un fortissimo mal di testa, cui è seguito il buio più totale: al risveglio, la prima cosa che ha visto è la scritta “enoizaminair” sulla porta di vetro della stanza in cui si trova. Un mistero da poco per una ragazzina sveglia: non le ci vuole molto a capire che si tratta dell’insegna dell’unità di “rianimazione” al contrario, per essere letta da chi in quelle stanze deve entrarci per lavoro. Ciò che non comprende, semmai, è cosa succeda in quel reparto, e perché lei si trovi lì.
Monica trascorre un mese e mezzo nel Sottosopra, a causa di un’emorragia cerebrale: se non è la cosa più strana, stranger thing, che possa capitare a una ragazzina di 13 anni, poco ci manca. A riscattarla da quella prigionia non è una coetanea con poteri soprannaturali ma un medico, che ha brutte notizie in serbo. «Disse ai miei genitori che non avrei più potuto fare sport. Ricordo che piansi a dirotto: dall’età di sei anni facevo parte della squadra di atletica leggera di Riccione». Tutto quello cui riesce a pensare è l’odore plastico del rosso tartan dell’ovale della pista, e il rumore regolare delle scarpe che lo calpestano: peccato che Monica, in quel momento, non riesca nemmeno a camminare. Quando il tempo lo permette e il sole splende, il lungomare di Riccione è un viavai di ragazzi che sfrecciano in bicicletta verso la prossima avventura: ed è proprio dall’osservazione di ciò che li circonda che alla famiglia di Monica viene in mente il modo per evitare che la figlia venga lasciata a piedi dalla vita proprio nel momento in cui dovrebbe essere più bello inforcarla. La ragazza in equilibrio sulla sella non riesce a starci: ma c’è un altro veicolo che, negli anni ’80, diventa il dittatore supremo di ogni viale, di ogni precedenza, di ogni senso unico della Riviera. È il risciò: una chiassosa automobile a pedali con cui condividere tratti di strada quando ancora non hai patente. Quello non ce l’hanno nemmeno i protagonisti di “Stranger Things”. Monica ce l’ha: gliel’hanno comprato i genitori come strumento di riabilitazione. Gli amici fanno la fila per salirci e, forse inconsapevolmente, aiutare Monica a riprendere l’uso delle gambe pedalando anche per lei. Quando non ci sono loro sul risciò sale il fratello: rigorosamente a destra, nel posto passeggero. Monica, il volante, non lo molla: stabilisce lei la rotta. «È da quell’esperienza che ho maturato la decisione di diventare infermiera: volevo insegnare ai pazienti che con la forza di volontà si può guarire». A vent’anni, sette anni dopo l’esperienza di un mese e mezzo nel Sottosopra, la scritta “enoizaminair” si ribalta definitivamente: in quel reparto, in quell’ospedale, Monica ci entra con le proprie gambe come membro dello staff sanitario. Tuttavia sappiamo come ogni serie TV che si rispetti, alla prima stagione, ne fa seguire altre, con vecchi nemici che tornano alla carica più agguerriti: o nuovi antagonisti, al cui confronto persino i rivali precedenti impallidiscono. “Stranger Things” non fa eccezione: Monica, purtroppo, nemmeno. «A 47 anni mi sono sottoposta ad una mammografia che ha rivelato un’anomalia al seno: sembrava una cosa da nulla, e invece dopo sei mesi si è scoperto essere un tumore». Di nuovo Monica sveste i panni dell’infermiera per tornare dalla parte dei pazienti. «Era una sensazione strana. Più volte mi sono chiesta perché mi venisse presa la vena: io avrei dovuto fare le punture, non riceverle». Al primo intervento ne segue un secondo dopo un anno: nel mentre, la chemioterapia. Quando il tempo lo permette e il sole splende, il lungomare di Riccione è un viavai di persone che si godono la passeggiata in centro tra gelati e vetrine. Tra questi anche Monica, che affronta la folla senza capelli, ma anche senza paura. «I miei figli un po’ si vergognavano, ma io volevo insegnargli una cosa importante: ci si vergogna di rubare, non di affrontare una malattia a testa alta». Giada, la più grande, è particolarmente sensibile e un po’ si chiude in sé: Jacopo, invece, è più diretto. «Aveva 8 anni e mi ricordo che mi chiedeva: mamma, ma se non hai più un seno, poi se avrai un altro figlio come farai? Mai avrei pensato che di lì a un anno mi avrebbero trovato un altro tumore, nell’altra mammella». Più che un colpo di scena, un colpo allo stomaco. Monica sa che, per considerarsi definitivamente guariti, occorre che trascorrano 5 anni: ma ogni anno, dal 2017, il conto alla rovescia si azzera e riparte da capo. Curiosamente è proprio il tumore che la convince a riprendere in mano le scarpette da jogging, dopo tanto tempo. «Nel mio percorso di cura ho scoperto che l’Istituto Oncologico Romagnolo stava dando vita al progetto Move Your Life: lo scopo era reclutare un gruppo di pazienti per un percorso di allenamenti volti a prendere parte alla Maratona di Rimini. Ho subito accettato: quello che mi è capitato mi ha insegnato a non sedermi sul divano a guardare la vita passare. Io non voglio solo veder crescere i miei figli: voglio correre insieme a loro». I partecipanti di Move Your Life creano molto più di un gruppo: creano dei vincoli d’amicizia inossidabili, come quelli che si stringevano a 13 anni nel 1983.